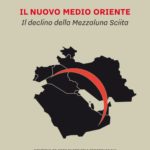
Il nuovo Medio Oriente. Il declino della Mezzaluna Sciita. Il libro di Giovan Battista Brunori

Le macerie di un presidente (Panorama 22.10.2025)
L’ombra lunga dei Fratelli Musulmani negli Stati Uniti: così l’entrismo islamista sfrutta la democrazia americana

L’entrismo della Fratellanza Musulmana negli Stati Uniti non è una teoria marginale né un riflesso dell’allarmismo post-11 settembre, ma un grande progetto strategico dichiarato nei documenti interni dell’organizzazione, dove la “jihad civilizzatrice” viene descritta come una lotta di lungo periodo per trasformare le società occidentali dall’interno. L’analisi dell’ISGAP (Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy), ricostruisce filoni dottrinali, metodi operativi e obiettivi a lungo raggio di un movimento che, pur rinunciando alla violenza in Occidente, non rinuncia a un impianto ideologico incompatibile con i valori democratici. Al centro c’è il tamkeen, il concetto di radicamento istituzionale: una strategia graduata, multigenerazionale, che punta a inserirsi nei gangli politici, giuridici, culturali e mediatici delle democrazie liberali. L’idea, sviluppata da Hassan al-Banna e radicalizzata da Sayyid Qutb, considera l’Occidente un ambiente da penetrare sfruttandone le libertà, neutralizzandone i meccanismi di difesa e acquisendo legittimità come interlocutore “ufficiale” delle comunità musulmane.
Documenti come “Il Progetto” del 1982 e il “Memorandum esplicativo” del 1991 descrivono un piano che non passa attraverso lo scontro frontale, ma attraverso la costruzione di reti parallele: centri culturali, associazioni di studenti, ONG, lobby legali, infrastrutture educative e finanziarie capaci di produrre consenso e modellare l’opinione pubblica. Il metodo è sempre lo stesso: inserirsi, radicarsi, diventare indispensabili, parlare a nome di tutti i musulmani americani, marginalizzando le voci riformiste e imponendo una narrativa unica che confonde religione e progetto politico. Gli ambiti di influenza individuati dallo studio sono quattro. Il primo è la politica, con un lavoro di pressione sul Congresso, sul Dipartimento di Giustizia e sulle agenzie federali. Nel tempo, gruppi allineati alla Fratellanza hanno ottenuto ruoli consultivi e spazi di interlocuzione privilegiata, incidendo su linguaggi e linee guida, soprattutto in materia di contrasto all’estremismo violento, dove hanno lavorato per eliminare riferimenti all’ideologia islamista. Il secondo è il campo legale: la Fratellanza ha compreso che il sistema statunitense consente un uso politico del contenzioso. Da qui l’esplosione di cause mirate contro studiosi, analisti, attivisti musulmani anti-islamisti e perfino Stati esteri ostili ai Fratelli.
Il concetto di “islamofobia”, riproposto come categoria quasi giuridica, diventa una leva per zittire il dissenso e scoraggiare le indagini. Il terzo ambito è l’infiltrazione istituzionale: scuole, centri religiosi, università, dipartimenti accademici e associazioni studentesche che diventano serbatoi di mobilitazione politica. Qui si innesta la saldatura con il movimento BDS e con la cosiddetta “alleanza rosso-verde”, il patto tattico tra islamisti e gruppi dell’estrema sinistra occidentale. Il quarto pilastro è il controllo narrativo, realizzato attraverso media tradizionali, social network, influencer accademici e programmi educativi che presentano la Fratellanza come voce moderata e legittima dell’Islam americano. Ogni crisi diventa un’opportunità. Dopo l’11 settembre, i gruppi collegati alla Fratellanza si proposero come interlocutori indispensabili nella gestione della “sensibilità comunitaria”, ottenendo accesso istituzionale in un momento in cui l’apparato statale cercava disperatamente referenti affidabili.
Tra il 2007 e il 2017, la mobilitazione nei campus universitari fece emergere una rete perfettamente organizzata, capace di influenzare amministrazioni, sindacati studenteschi e università prestigiose. Dopo il 7 ottobre 2023, la rapidità con cui le mobilitazioni pro-Hamas si sono attivate – in particolare nei campus – ha mostrato il livello di integrazione tra strutture di lungo periodo, attori accademici, reti digitali e gruppi politici progressisti. Lo studio evidenzia come l’assenza di strumenti adeguati da parte delle democrazie occidentali abbia favorito questo processo. I sistemi di sicurezza – pensati per individuare minacce violente – non intercettano strategie che si muovono nel perimetro della legalità. Le leggi contro la discriminazione, nate per proteggere minoranze vulnerabili, vengono utilizzate per bloccare critiche legittime. Le istituzioni accademiche, prive di trasparenza finanziaria e spesso ostaggio di pressioni ideologiche, diventano acceleratori di radicalizzazione politica. Il risultato è una forma di estremismo non violento che opera senza violare apertamente la legge, ma con effetti destabilizzanti sulla tenuta democratica: normalizzazione del discorso radicale, costruzione di società parallele, erodimento della fiducia pubblica, delegittimazione dei meccanismi di difesa istituzionale. La conclusione dello studio è netta: la Fratellanza non mira alla violenza immediata, ma a una trasformazione graduale e irreversibile dell’ecosistema civico occidentale. La domanda, oggi, è se le democrazie siano in grado di riconoscere un fenomeno che non si presenta con armi e bandiere, ma con linguaggi inclusivi, cause progressiste, strutture associative e un progetto ideologico che procede, silenziosamente, da quasi un secolo.
